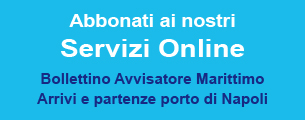di Giovanni Grande
Manifatturiero, portualità e logistica, agricoltura e turismo sono i cinque pilastri su cui si può fondare il rilancio economico del Mezzogiorno per integrare di più il Sud nell'Italia e nell'Ue. Un'opportunità per portare l'Italia «a diventare in Europa come Francia e Germania» rilanciando la questione di interesse nazionale dello sviluppo del Meridione. La premessa di Economia Reale nel Mezzogiorno (Il Mulino 2014), volume a cura di Alberto Quadrio Curzio e Marco Fortis, non si limita alla semplice presa d'atto dei divari che separano la penisola. Misura i punti di eccellenza nell'area, i nuclei di forza che, pur dimostrando una forte carica di innovatività, non riescono a diventare rete e a rispondere alla domanda di un bacino di 26 milioni di abitanti. Un'analisi inedita che implica una posizione forte e non necessariamente scontata. La soluzione, infatti, starebbe nella «logica industriale» secondo gli autori, nella necessità che criteri di razionalità organizzativa improntino il sistema territoriale, «per sottrarlo alla discrezionalità di interventi finanziari intermediati e distorti da un sistema istituzionale che orienta le risorse in tanti rivoli di consenso sociale, portando a quell'assistenzialismo di cui le risorse umane del Mezzogiorno, molto qualificate, non hanno necessità».
Il sud non è un deserto industriale
Frutto di un lavoro collettivo, la raccolta di saggi presentata il 22 ottobre da SRM – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno nella sede del Banco di Napoli, prende le mosse, ampliandone i temi, da un importante convegno promosso un anno fa da Fondazione Edison e Accademia dei Lincei. Un tentativo di tratteggiare un nuovo approccio al problema al di là di criticità, stereotipi e sentimenti di rassegnazione; mettendo al centro, senza tralasciare gli effetti negativi della congiuntura, un quadro economico non obbligatoriamente deficitario. Basti pensare, ad esempio, al valore aggiunto manifatturiero che, per le regioni meridionali nel loro insieme, supera quello di intere nazioni come Finlandia, Romania o Danimarca (con contributi alle esportazioni nazionali di tutto rispetto, come il 31% del settore aeronautico, il 17% dell'automotive, il 18% dell'agroalimentare e il 13% dell'export farmaceutico). O alle posizioni di preminenza nei comparti della produzione di ortaggi, frutta fresca o del turismo internazionale. «La descrizione di un Sud deserto industriale non è veritiera», sottolineano gli autori. Seppur con meno densità che al Centro-Nord vi sono imprese che «innovano, producono ed esportano resistendo alla crisi con tenacia».
Su quale leve puntare, allora? Innanzitutto, la «cooperazione tra attori privati, e tra questi e le istituzioni pubbliche, nel produrre i beni collettivi di cui c'è bisogno». «Lo sviluppo del Nord Italia ha fruito molto nel corso di quasi due secoli – sintetizza il professor Quadrio Curzio – della commutazione tra forze sociali e istituzionali e forze economiche e tecno-scientifiche». Sul piano operativo, invece, sarà essenziale, insieme ad un impiego più efficace delle risorse messe a disposizione dal prossimo ciclo delle politiche europee e da un'attenta scelta delle priorità strategiche, perseguire l'integrazione settoriale. Quella complementarietà tra comparti produttivi che in regioni come Emilia – Romagna, Veneto e Lombardia «determina delle economie che da esterne diventano interne»; fenomeno poco presente nel Sud dove «ogni settore è poco connesso agli altri».
Nel sud l'industria è il porto
Fondamentale, in questo contesto, il ruolo propulsivo di portualità e logistica, potenziale moltiplicatore per una vocazione all'export che nella consolidata direttrice del Nord America e in quella in crescita esponenziale dell'interscambio mediterraneo, trova le naturali vie di sbocco. Considerazioni queste che non rappresentano una novità. Un terzo dell'interscambio commerciale italiano – ricorda il volume – avviene con modalità marittima: il dato sale al 63% se si considera il solo Mezzogiorno e raggiunge un 76% se si prende a riferimento l'area Sud del Mediterraneo (qui, nonostante le "primavere arabe", i tassi di crescita sono invidiabilmente solidi, 3-4%, se paragonati all'asfittica situazione continentale). Senza contare l'incidenza di un settore imprenditoriale che nella filiera conta oltre 45 mila imprese, concentrate per lo più in Campania, Sicilia e Puglia.
E proprio dallo stato della portualità emerge con forza la necessità di un cambio di paradigma, di una nuova stagione in grado cogliere i frutti dell'"economia reale". Il caso del porto di Napoli, sotto questo aspetto, è emblematico. Difficoltà ad accedere, quando non vero e proprio rischio di perdere, i finanziamenti europei; mancanza di obiettivi strategici; rimpallo di responsabilità politiche e istituzionali. Un cocktail mortale che rischia di affondare la principale azienda della città. «Occorre comprendere che la filiera dell'economia del mare è fondamentale per la capacità competitiva delle imprese; una priorità che è del Mezzogiorno ma – in simbiosi – lo è per l'intero Paese e per la sua collocazione geo-economica». Un'esortazione che non può non tener conto di una contraddizione tra la dimensione di terra – porto e retroporto – e quella di mare – armatori e operatori dello shipping. «Non è un caso che l'attività armatoriale, per sua natura svincolata dal territorio, registri in Campania, in particolare, e nel Sud Italia, in generale, livelli assoluti di eccellenza» spiega un profondo conoscitore del settore come Umberto Masucci, presidente del Propeller Club partenopeo. «Sul lato banchina, invece, si sconta la tipica patologia della politica meridionale». Un'inefficienza paralizzante che va combattuta "incalzando" sempre più le istituzioni verso «una nuova governance dei porti e la semplificazione di procedure e meccanismi in grado di garantire la continuità delle esperienze di buona amministrazione».
Liberalismo sociale
Una nuova impostazione, dunque, per un nuovo meridionalismo che Quadrio Curzio e Fortis declinano come "liberalismo sociale", alla ricerca di una dialettica «tra le parti solide o potenzialmente tali della politica e della società con quelle che hanno dimostrato la loro solidità nelle attività d'impresa». Un'inedita forma di rappresentanza che a Napoli sperimenta nuove iniziative partendo dal perimetro dell'attività portuale, come nel caso della Consulta delle Associazioni degli Operatori Portuali. «Il tentativo – sottolinea il presidente degli agenti marittimi, Andrea Mastellone – di mettere insieme sotto l'ombrello delle due principali associazioni, Unione Industriali e Confcommercio, una filiera produttiva interessata alla valorizzazione infrastrutturale, al superamento di problematiche che frenano l'intero sistema, a combattere, anche, un clima eccessivamente pessimistico sul futuro». Contribuendo, magari, anche a prevenire quelle storture che, denunciano gli autori del volume, nella portualità sono state conseguenza di una concezione rigidamente macroregionale. «Perso nei campanilismi più deteriori, il nostro paese ha dimenticato di guardare con uno sguardo d'insieme alla sua naturale vocazione geografica. Spesso si è contrapposto il legame Centro-europeo del Nord Italia con quello Mediterraneo del Sud della Penisola come fossero opzioni alternative. Questo strabismo si è poi accentuato nell'ultimo quindicennio, dove un regionalismo mal inteso e mal interpretato ha esasperato questa dicotomia».