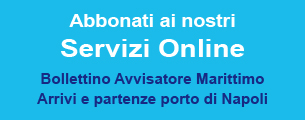I grattacapi degli assicuratori e il destino della logistica in Italia di fronte a bestioni da oltre 15mila teu che condizioneranno, direttamente o indirettamente, il futuro del trasporto in Italia. Di questo si è discusso oggi a Roma al convegno organizzato da Federagenti Il confine dei giganti che, oltre ai saluti del presidente Michele Pappalardo, ha visto le relazioni di professori e analisti.
Saranno pochi i porti italiani che potranno ospitare le grandi navi portacontainer, e neanche le più grandi: fino a un massimo di 15mila, forse in casi eccezionali 16mila teu. E ciò non solo perché le infrastrutture portuali e le dimensioni dei nostri porti non consentono l'ingresso di navi da 21mila teu lunghe quattro campi di calcio di San Siro, larghe 60 metri e con uno scafo immerso per oltre 17 metri. I motivi sono due. In Italia non c'è una concentrazione di porti-container. In secondo luogo le strategie degli armatori sulle grandi portacontenitori prediligono rotte Asia-Europa direttamente collegate al northern range, dando al Mediterraneo un ruolo di trasbordo. In altre parole, i giganti del mare non arriveranno in Italia, questo è sicuro. La questione è: quali saranno le conseguenze per la nostra economia?
La fragilità della logistica italiana
Gli agenti marittimi, e più in generale l'intero cluster marittimo italiano, denunciano una fragilità complessiva del sistema Italia. Secondo il presidente Federagenti Michele Pappalardo non ci sono attualmente interventi legislativi, regolatori e infrastrutturali nel settore. Il paese perciò si trova a subire passivamente scelte sulle quali non può incidere perché non può contare sulla definizione di un piano logistico (tenendo anche conto che quello che il governo sta preparando è in parte incostituzionale) né su scelte precise su quali porti (e quali sistemi infrastrutturali coerenti) potranno ambire a un ruolo sulle grandi rotte del trasporto container. «La rivoluzione in atto nel mercato dei container – secondo Pappalardo – implica la messa in campo di una macchina organizzativa seria. E i tempi per costruirla sono terribilmente stretti». Questa incertezza risulta ancora più rischiosa vista la lontananza dalle coste italiane delle navi giganti, oggetto di contratti di costruzione sempre più frequenti da parte delle grandi compagnie di trasporto container. «La scelta dei grandi gruppi armatoriali ha una sua logica» secondo Pappalardo: «in un mercato dei noli che ormai da quasi dieci anni ha prua verso il basso, le economie di scala garantite da queste navi forniscono una risposta logica».
Secondo il professore Sergio Bologna il mondo marittimo, dove viaggiano il novanta per cento dei beni di consumo, rischia una grande bolla finanziaria. Negli ultimi cinque anni la flotta mondiale per il trasporto merci è cresciuta a un tasso medio del 7 per cento, a fronte di una recessione economica mondiale e di una domanda globale di beni di consumo che non supera il 6 per cento annuo. A questo si aggiunge una flessione del tasso di sviluppo della Cina. Tassi di crescita della capacità della flotta quasi a doppia cifra a fronte di una crescita media del due per cento del Pil mondiale. L'Italia rischia di subire non solo l'impatto dello squilibrio fra domanda e offerta ma anche una crescente emarginazione dalle grandi rotte dell'interscambio mondiale.
Navi giganti inassicurabili
Fino al 2006 era Guangzhou Cosco la portacontainer più grande con i suoi 9,500 teu di capacità. Nello stesso anno è seguita Emma Maersk da 13mila teu. Nel 2014 è arrivata Cscl Globe da oltre 19mila teu. All'inizio di quest'anno Msc Oscar, Msc Oliver ed Msc Zoe, che con 19.200 teu sono attualmente le più grandi costruite. Nel frattempo sempre quest'anno Maersk ha ordinato ai cantieri coreani Daewoo unità da oltre 20mila teu. Curiosamente, sono navi che crescono soltanto in ampiezza: Emma Maersk è lunga 397 metri, Msc Oscar 396. Navi sempre più grandi ma sempre meno cariche di merci in proporzione per via della crisi economica. Così i tassi di nolo degli spazi dove ospitare i container sono oggi più bassi del 2008, raggiungendo oggi i 1.080 dollari per teu.
Assicurare questi bestioni è molto complicato. «Mentre il valore di una ultra large container vessel sarebbe di 200 milioni – spiega il direttore operativo Siat Assicurazioni Alessandro Morelli – il valore del carico varierebbe tra gli 800 milioni e il miliardo con un carico all'80 per cento della capacità. Una stima che riguarderebbe solamente nave e del carico, senza prendere in considerazione la rimozione del relitto».
Gigantismo sintomo della finanziarizzazione dello shipping
In un mercato che ha cercato di ritrovare margini di redditività facendo viaggiare a velocità ridotta le navi o procedendo a fusioni e concentrazioni, la corsa al gigantismo è solo apparentemente motivata dal raggiungimento di economie di scala. In realtà il corollario di incentivi statali e bancatri permette agli armatori (questo in generale da sempre, ma ancor di più oggi) di costruire a prezzi molto bassi. Risiede più qui la corsa al gigantismo piuttosto che in un generico "ottimismo" di facciata sul futuro del mercato. «La finanza dello shipping – spiega Bologna – assomiglia al settore immobiliare. Le banche hanno elargito generosamente crediti alla costruzione di navi perché avevano in garanzia un bene materiale, la nave. A questo si aggiungono, come fattore distorsivo del mercato, i generosi sussidi pubblici forniti alla cantieristica del Far East. Sono state costruite navi dotate dei dispositivi più sofisticati e vendute a prezzi stracciati». Lo shipping si è finanziarizzato, e non è una bella notizia. «La nave – spiega Bologna – è sempre meno uno strumento del commercio mondiale e sempre più un puro asset finanziario. Le banche esposte nel credito all'armamento cedono i loro non performing loans a cosiddetti "fondi avvoltoio" che s'impadroniscono di beni già svalutati e li cedono sul mercato dell'usato».
Cosa succederà quando queste navi imbarcheranno e sbarcheranno in poche ore volumi mai visti di container?
Le opportunità del gigantismo
Le economie di scala, come osserva il professore Acciaro, è tale solo se anche le infrastrutture a terra siano altrettanto "giganti", «altrimenti si parla di economia di densità, che sono già esaurite». Acciaro non vede nel gigantismo il colpo di grazia alla singhiozzante logistica italiana, piuttosto rappresenta un'altra opportunità. «Se da una parte è vero che gli scali italiano non hanno la rendita di posizione di Amburgo o Rotterdam – spiega Acciaro -, è vero che anche la dotazione infrastrutturale a mare di alcuni dei nostri porti, Vado e Trieste per esempio e la posizione di porti del Nord Tirreno e Adriatico, non ha nulla da invidiare ai porti del Nord Europa. Il gigantismo potrebbe essere l'incantesimo del pifferaio magico necessario a risolvere alcuni problemi del sistema portuale italiano, perché l'utilizzo di queste navi potrebbe favorire l'emergere di nuovi hubs». Per esempio riprendendo il transhipment, anche se, di fronte a questi colossi i porti di trasbordo non dovrebbero essere più "puri" ma svilupparsi anche in altre attività. «Come stanno facendo Tangeri e Port Said – conclude Acciaro -, sviluppando nuove attività logistiche nel tentativo di consolidare la loro posizione di porto di adduzione».
Il convegno, dopo i saluti di Paolo Uggè (Confcommercio) ha visto confrontarsi in una tavola rotonda il presidente di Assoporti, Pasqualino Monti, il presidente di Assiterminal, Marco Conforti, l'amministratore delegato di Fercam, Thomas Baumgartner e Ignazio Messina, amministratore delegato della Ignazio Messina & C. Le conclusioni sono state tracciate dal dirigente del ministero dei Trasporti Ivano Russo.